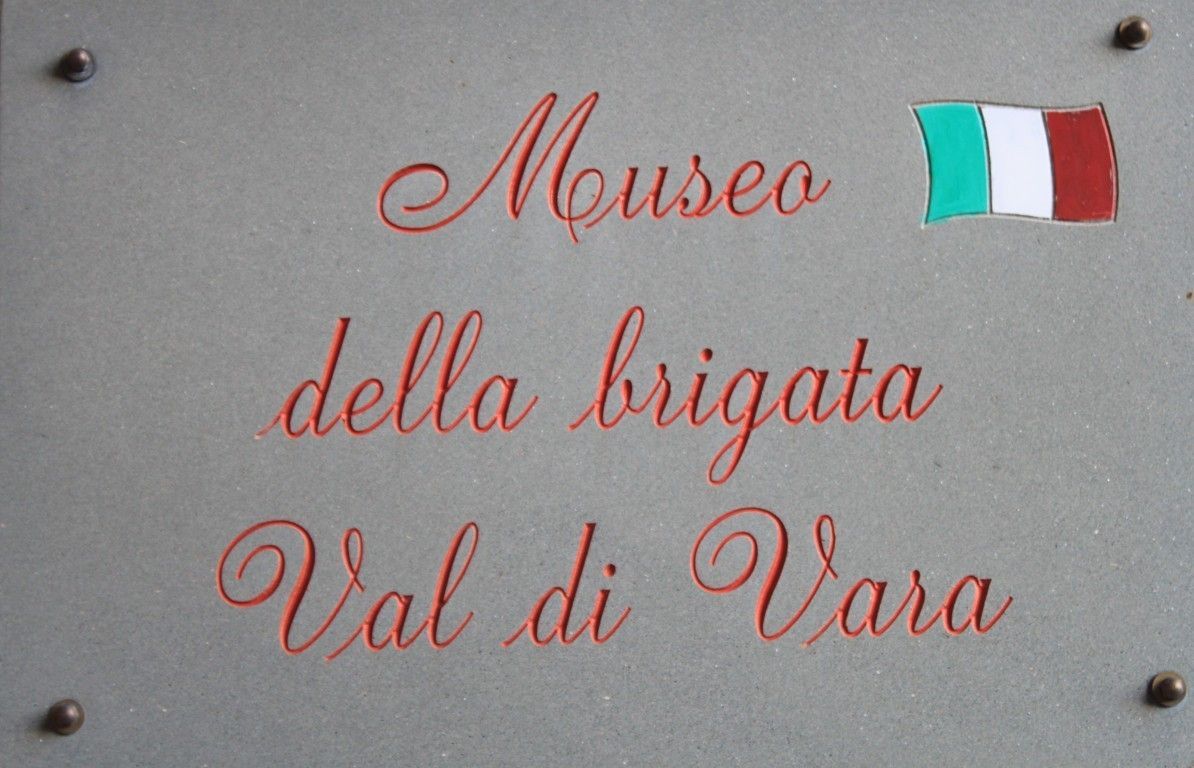Il miele di Calice al Cornoviglio
Un territorio e la sua dolcezza.
Il legame del miele con il territorio di Calice e la cultura per questo prodotto risale a molti anni fa, già nella prima metà dell’ottocento esistono testimonianze che ci permettono di affermare che esistevano contadini che integravano con questa attività se pur marginale e senza conoscenze approfondite il loro reddito, spesso recuperavano dai tronchi di alberi il miele con metodi rudimentali, nella maggior parte dei casi le api non sopravvivevano altre volte venivano appositamente soppresse per facilitare il recupero. La prima evoluzione si è avuta nella sconda metà dell’ottocento, quando andò diffondendosi la tecnica dell’allevamento con l’utilizzo dei bugni rustici, una porzione di albero della lunghezza di 80-90 cm e del diametro di circa 30- 40 cm veniva completamente svuotata, all’interno si collocavano due bastoncini solitamente incrociati per facilitare la costruzione dei favi. Il tronco veniva poggiato su un piano in legno o in pietra in modo che rimanesse stabile in posizione verticale, l’apertura in alto veniva chiusa con una lastra per proteggere le api dalle intemperie, nella parte bassa o in quella centrale veniva praticata un’apertura di qualche centimetro per permettere l’ingresso alle api. Solitamente questi bugni venivano popolati raccogliendo sciami naturali che facilmente in primavera si poggiavano fuoriusciti da cavità di alberi, anfratti o anche da altri bugni sulle piante vicine. Questa tecnica nonostante fosse da considerare una prima forma di allevamento aveva moltissimi limiti, il principale era quello che purtroppo si praticava l’apicidio al momento della raccolta del miele. Nei primi anni del 1900 l’uso del bugno rustico nel territorio Calicese era molto diffuso tanto che quasi ogni famiglia ne possedeva alcuni, producendo miele per soddisfare le proprie necessità. Ricorda Montanari Lino che quando era bambino, suo padre Umberto possedeva almeno una ventina di famiglie, nel mese di ottobre si effettuava la raccolta del miele, mediante una apposita sgorbia a manico lungo, (attrezzo conservato all’interno del Museo) costruita in loco, si procedeva al distacco dei favi contenenti il miele dall’interno dei bugni, il tutto veniva stoccato in contenitori di legno adatti per il trasporto su animali (nella forma dialettale Calicese sono chiamati soghi). Guerrieri Roberto di professione mulattiere si occupava di raccogliere questi contenitori da vari produttori e di conferirli nel Pontremolese dove il miele era venduto, l’appuntamento si ripeteva ogni anno ed erano necessari più viaggi per poter conferire tutta la produzione. Tra gli apicoltori più importanti del periodo ricordiamo Umberto Montanari e Guerrieri Antonio a Villagrossa, Saccomani Costante a Debeduse, Rapallini Vittorio loc. Borasco, Paita Dante e Andreoni Natale a Santa Maria, Andreoni Narciso loc. Campi.
Nei decenni successivi andò affermandosi un tipo di allevamento sempre più razionale con l’introduzione dei favi mobili montati su telaietti in legno che permettevano il controllo delle api e l’estrazione del miele preservando la famiglia, sebbene non si trattasse ancora di arnia razionale si poteva già parlare di un allevamento evoluto, il limite era legato al fatto che diversi apicoltori costruivano delle casse in legno con telai mobili, ma che spesso avevano forme e misure diverse limitando la possibilità di interscambio. In queste casse si iniziarono a trasferire i bugni rustici mediante una tecnica particolare che a quanto pare è fu ideata, realizzata e utilizzata proprio nella nostra zona, si trattava di posizionare al posto della piastra superiore una tavola in legno con un’apertura circolare del diametro del tronco in modo da realizzare una tenuta sufficiente da evitare la fuoriuscita delle api, su questo piano veniva appoggiata la cassa contenente i telai su cui erano state fissate (quando erano disponibili ) piccole striscioline di cera, per indirizzare le api a costruire in quella zona. A questo punto irrorando dal basso (solitamente dall’apertura che le api utilizzavano come ingresso) abbondanti quantità di fumo, si costringeva le api risalire verso l’alto e ad andare ad occupare la nuova dimora. Completato il trasferimento, il bugno rustico veniva tolto e la nuova cassa veniva collocata al suo posto.